Sandro Mezzadra*
Consentitemi di cominciare ringraziando gli organizzatori della “Biennale della democrazia”, e in particolare il Prof. Gustavo Zagrebelsky, per avermi invitato a tenere questo intervento. Vorrei poi ringraziare anche l’amica Simona Forti per le sue parole introduttive, decisamente non formali. Sono felice di essere con voi oggi, in questo forum in cui si pratica la democrazia, anche se devo dire che ho un certo rammarico per non potere partecipare alla manifestazione transfemminista di Verona contro il cosiddetto “Congresso mondiale delle famiglie”, un altro luogo in cui in queste ore la democrazia viene messa in pratica e in gioco. Dopo qualche considerazione di carattere generale sul tema della “Biennale”, vi proporrò una digressione storica, per concentrarmi nell’ultima parte del mio intervento sul modo in cui la democrazia è interrogata, in qualche modo sfidata dalla figura dello “straniero”, ovvero del migrante.
1. Democrazia, devo confessarlo, è oggi parola che ha per me un suono un po’ spaesante, potrei perfino dire “perturbante” con un riferimento a quella dialettica di familiare ed estraneo che ne definisce il concetto per Freud. Da una parte, come resistere all’impressione che la democrazia sia in qualche modo esausta, svuotata da un insieme di processi e di poteri che ne aggirano continuamente le procedure, le forme e lo stesso “spirito”? Se siamo tutti familiari con le analisi dei processi contemporanei di governo (o di governance) che ne sottolineano la natura ormai compiutamente “post-democratica”, abbiamo anche chiara la sensazione che la nostra vita sia dominata da potenze – dai mercati finanziari globali al cambiamento climatico alle grandi piattaforme digitali – che si presentano come indifferenti alla presa e alla pretesa regolativa della democrazia. E gli effetti dell’azione di queste potenze, non ci si inganni, sono direttamente politici. Dall’altra parte, non è forse vero che alcuni dei movimenti sociali più innovativi del nostro tempo, nel momento stesso del loro insorgere, parlano quasi naturalmente il linguaggio della democrazia? Democracia real, ya!, per fare un solo esempio, è stato lo slogan del movimento che ha occupato le piazze spagnole nel 2011, riprendendo le indicazioni che venivano da Paesi come la Tunisia e l’Egitto e dando luogo a un ciclo globale di mobilitazioni.
Dobbiamo dunque fare i conti con quanto vi è oggi di perturbante nella parola democrazia. Per quel che mi riguarda, ho sempre seguito autori classici, come Spinoza e Marx, ma anche un sociologo novecentesco come Tom Marshall (l’autore di Cittadinanza e classe sociale), nel pensare che della democrazia sia necessario sviluppare un concetto doppio, in un certo senso diviso. Democrazia nomina infatti un sistema istituzionale, che si è venuto organizzando attorno alla rappresentanza politica e di cui abbiamo molteplici realizzazioni – dagli Stati Uniti d’America all’India, per menzionarne due particolarmente significative sia dal punto di vista storico sia dal punto di vista del nostro presente. Ma democrazia nomina anche un movimento, una spinta che certo si può definire alla democratizzazione ma che infinite volte – dalle lotte delle donne alla rivolta degli afro-americani contro la segregazione nel Sud degli Stati Uniti, dai movimenti dei Dalit in India alle rivendicazioni dei migranti senza documenti in Italia – si è rivolta e si rivolge contro sistemi che si definiscono democratici. Dunque, un sistema istituzionale e un movimento: questo è per me la democrazia, e la sua storia politica non è pensabile al di fuori della tensione e del conflitto tra quelle due dimensioni. Tensione, conflitto, e certo anche dialettica: la mia impressione, per dirla un po’ rapidamente, è tuttavia che da qualche tempo la dialettica si sia interrotta e che oggi ogni discorso sulla democrazia debba assumere come proprio punto di partenza questa interruzione.
Ma siamo qui chiamati, nell’edizione di quest’anno della “Biennale della democrazia”, a riflettere su un tema tanto affascinante quanto impegnativo, quello definito dai due termini “visibile” e “invisibile”. Termini evidentemente cruciali per una forma politica, quella democratica, che ha sempre assunto la trasparenza del potere come proprio riferimento essenziale. Lo “Stato profondo”, gli apparati che operano nell’ombra sulla traccia antica degli arcana imperii sono sempre stati la bestia nera della democrazia. Questi apparati non hanno certo smesso di operare. Ma oggi parlare di “visibile” e “invisibile”, e ne sono ben consapevoli gli organizzatori della “Biennale”, costringe a confrontarsi con un insieme ulteriore di questioni, che portano scompiglio in quella grande divisione tra il “pubblico” e il “privato” che la democrazia in quanto sistema istituzionale ha sempre in qualche modo assunto come proprio presupposto (pur subendo la sfida radicale di grandi movimenti sociali, in primis di quello femminista, che ha colto proprio nel “privato” il momento costitutivo del patriarcato, “invisibile” alla democrazia). La “visibilità” oggi invade le nostre vite, lo stesso “io” è sollecitato a sovraesporsi, illuminato da una luce pubblica che non è certo quella dello Stato, ma piuttosto quella dei social media e di un insieme di piattaforme che plasmano il nostro quotidiano. Al riparo da quella luce, del resto, un insieme di poteri lavora alla continua scomposizione e ricomposizione dei dati che definiscono i nostri molteplici profili, sottraendo la nostra “identità” al nostro controllo. Il caso “Cambridge Analytica” ha mostrato a tutti noi quale sia il potenziale impatto direttamente politico delle tecnologie di data mining sotto il profilo della manipolazione della cosiddetta “opinione pubblica”. Ma la questione ha certo per la democrazia, comunque la si voglia definire, un rilievo che va al di là di questo pur decisivo impatto.
“Visibile” e “invisibile” in riferimento alla democrazia, dunque. Sviluppando alcune indicazioni del filosofo francese Jacques Rancière, parlerei di “regimi di visibilità” che contraddistinguono la democrazia. Rancière parla di “partizione del sensibile” a proposito di un sistema che rende “contemporaneamente visibile l’esistenza di qualcosa di comune e le divisioni che, su tale comune, definiscono dei posti e delle rispettive parti”. Si vede bene come questa definizione si attagli alla democrazia (e più in generale alla politica): il doppio riferimento al “comune” e alle “divisioni” trascrive la grande questione del rapporto tra inclusione ed esclusione nel registro del “visibile” e al tempo stesso turba la nitidezza del rapporto tra ciò che è interno e ciò che è esterno alla democrazia (nel senso che determinati soggetti possono benissimo sentirsi a disagio nelle “parti” che sono loro attribuite da uno specifico “regime di visibilità”). È nota l’importanza che Rancière attribuisce, soprattutto nel suo libro Il disaccordo (1995), alla “parte dei senza parte”, a quegli “invisibili” la cui insorgenza e i cui movimenti scompigliano la “partizione del sensibile” e aprono lo spazio in cui diviene possibile la riqualificazione dell’uguaglianza democratica. Credo che sia un’indicazione importante per noi, che ci ricorda un significato essenziale del termine “invisibile” in riferimento alla democrazia. Non dovremo tuttavia dimenticare l’altro significato del termine, quello che in qualche modo lo collega a ciò che vi è di osceno nella democrazia. Achille Mbembe, in un libro appena uscito in italiano (Nanorazzismo. Il corpo notturno della democrazia), legge ad esempio in questo modo le forme pervasive con cui il razzismo penetra all’interno delle nostre società democratiche.
Parlare di “visibile” e “invisibile” a proposito della democrazia non può dunque che tenere insieme entrambi i significati dell’invisibilità. Significa parlare di donne e uomini migranti senza documenti che occupano una casa; ma significa anche parlare del corpo di Stefano Cucchi straziato dall’accanimento di servitori dello Stato democratico, “nei secoli fedeli”, in una notte romana. Significa parlare dell’adolescente Rami Shehata, invisibile alla cittadinanza del Paese in cui è nato, che si chiede come mai solo a lui, ordinario eroe, e non anche ai suoi fratelli e ai suoi amici debba essere riconosciuta quella cittadinanza; ma significa anche parlare dell’indifferenza, se non del piacere sottile e inconfessabile di fronte a migliaia di morti in mare che si diffonde nel nostro democratico Paese. Nel resto di questo intervento parlerò degli “invisibili” soprattutto nel primo senso, guardando ai movimenti dei soggetti costruiti come tali da uno specifico regime di “visibilità”, ma cercherò di tenere ben presente anche il secondo senso, quello che ho chiamato l’“osceno della democrazia”.
2. Vorrei ora cambiare registro, per proporvi – con una breve digressione storica – qualche immagine, non molto di più, della democrazia come si presenta nell’esperienza e nelle lotte di soggetti che specifici “regimi di visibilità” costruiscono come invisibili, o forse meglio come soggetti la cui visibilità è radicalmente diversa da quella del cittadino democratico. Mi soffermerò brevemente su due momenti assai importanti nella storia della democrazia (per quanto non necessariamente “canonici”): lo sviluppo del movimento nazionalista anti-coloniale in India tra le due guerre mondiali e l’evoluzione della democrazia statunitense all’inizio del Novecento, nella cosiddetta “età progressista”. Bhimrao Ramji Ambedkar, colui che sarebbe poi divenuto il padre della Costituzione indiana del 1950, scrisse nel 1936 un formidabile manifesto delle rivendicazioni dei Dalit, i cosiddetti “intoccabili”: Annihilation of Caste. In questo testo Ambedkar descrive con un piglio che si potrebbe definire “anatomo-politico” la formidabile spinta dei Dalit, tanto nelle lotte sociali quanto nelle lotte politiche, per entrare a pieno titolo all’interno del movimento nazionalista e dunque nel progetto di un’India indipendente. Questa spinta si scontra continuamente, anche all’interno degli scioperi operai, con un “mostro”, con quel sistema delle caste senza distruggere il quale – scrive Ambedkar – “non è possibile né una riforma economica né una riforma politica”. La polemica di Ambedkar con i dirigenti del movimento nazionalista è molto dura, e investe direttamente Gandhi: da che parte sta la democrazia in questa polemica? Gandhi immagina la futura India indipendente sulla falsariga della modernità occidentale, secondo un processo di formazione di una nazione omogenea che in realtà replica e conferma una divisione essenziale, quella appunto connessa al sistema delle caste. Ambedkar, seguendo il filo dei movimenti e delle rivendicazioni dei Dalit, di milioni di “invisibili”, pensa in modo ben più radicale la lotta per l’indipendenza e per la democrazia, ponendo al suo centro la distruzione del sistema delle caste e prefigurando una sofisticata composizione di differenze – fin sul piano giuridico – come suo esito. Un programma che continua ad avere un’indubbia attualità nell’India di oggi, stretta nella morsa del fondamentalismo indù.
Nel 1946, alla vigilia dell’indipendenza indiana, Ambedkar scrisse una lettera al grande intellettuale e attivista afro-americano W.E.B. Du Bois, richiamando la sua attenzione sulle analogie tra la posizione dei Dalit in India e quella degli afro-americani negli Stati Uniti. Du Bois, per parte sua, aveva articolato nei primi anni del Novecento una comprensione molto peculiare della democrazia come movimento, in quell’“età progressista” che è stata anche caratterizzata dall’esplosione dei linciaggi e dalla segregazione razziale nel Sud del Paese nonché dalla formazione dei primi ghetti nelle metropoli del Nord. Du Bois è figura di straordinario fascino e di grande complessità: vorrei qui soffermarmi soltanto su un aspetto della sua riflessione, che investe direttamente il concetto di democrazia. Focalizzando la sua attenzione sullo scandalo della razza (sull’osceno della democrazia americana, dunque), egli espone in piena luce i limiti e le contraddizioni della libertà e della democrazia statunitense. Ne legge lo sviluppo storico (e le potenzialità) non nei termini del graduale sviluppo di principi “universali”, ma a partire dal ruolo svolto dai movimenti e dalle lotte di soggetti – gli afro-americani, in primo luogo – collocati dalla storia della tratta e dell’“istituzione peculiare” della schiavitù in una posizione parziale e assolutamente “particolare” – nel cono d’ombra della libertà e della democrazia, appunto.
Un libro di Du Bois del 1924, The Gift of Black Folk, rappresenta precisamente il tentativo di rileggere la storia della presenza dei neri negli Stati uniti dal punto di vista del contributo da loro apportato – attraverso un’“incessante lotta” per la libertà – a un allargamento delle basi della democrazia americana. Ma c’è di più: a partire da questo posizionamento di parte, Du Bois guarda allo sviluppo di altri movimenti sociali che gli sembravano indirizzarsi verso un approfondimento e un’estensione della democrazia analoghi a quelli da lui auspicati dal punto di vista degli afro-americani. Segue in questi anni gli scioperi operai e la crescita del movimento sindacale, sostiene le lotte delle donne, si schiera senza indugi dalla parte di quei “nuovi immigrati” che subiscono lo sfruttamento nelle fabbriche statunitensi e sono al tempo stesso violentemente attaccati dai sostenitori del cosiddetto “nativismo”. Contro lo spirito del “privilegio” che permea un sistema politico e sociale che si definisce comunque democratico, Du Bois invoca una “grande alleanza dei popoli più scuri in tutto il mondo, tra gruppi svantaggiati come gli irlandesi e gli ebrei, e tra le classi lavoratrici ovunque”, includendo anche gli italiani tra quanti subiscono una essenziale “spoliazione dei diritti”.
3. Attraverso Ambedkar e Du Bois ho evocato due esperienze di lotta per la democrazia i cui protagonisti sono soggetti – i Dalit, gli afro-americani – a cui specifici regimi di visibilità democratica (quello del movimento nazionalista indiano e quello del sistema istituzionale statunitense) assegnano posizioni radicalmente subordinate. Sono per molti versi “invisibili”, condividono una condizione di mancata appartenenza, sono in fondo stranieri interni. Nella militanza politica di Du Bois, in particolare, questa mancata appartenenza si pone come base per la composizione di originali coalizioni politiche, che includono come componenti fondamentali i “nuovi immigrati”, stranieri a tutti gli effetti. Proprio sulla figura dello straniero, sul suo rapporto con la democrazia in quanto sistema istituzionale e in quanto movimento vorrei soffermarmi nella parte conclusiva del mio intervento. È un tema classico, e non si dovrà dimenticare che esiste una linea di teoria della democrazia, che insistendo sull’omogeneità del popolo, del demos come suo presupposto stabilisce un confine molto netto nei confronti dello straniero, un confine che si presta a nutrire forme più o meno radicali di esclusione e ostilità. “Il concetto centrale della democrazia”, scrive ad esempio Carl Schmitt nella sua Dottrina della costituzione (1928), “è il popolo e non l’umanità”. Non possiamo dunque presupporre la benevolenza della democrazia nei confronti dello straniero.
Possiamo certamente, tuttavia, identificare linee di riflessione radicalmente diverse sul rapporto tra la democrazia e lo straniero. Continuano a essere straordinariamente attuali, da questo punto di vista, le pagine dedicate da Georg Simmel nella sua Sociologia (1908) alla “forma sociologica dello straniero”. Lo straniero di cui Simmel parla non è notoriamente né colui che vive in terre lontane né “il viandante che oggi viene e domani va”; è piuttosto il migrante, “colui che oggi viene e domani rimane”. Con un’analisi elegante e raffinata, Simmel richiama l’attenzione sulla contemporanea internità ed esternità dello straniero così definito al “gruppo sociale”, sulla posizione liminale che questi occupa dal punto di vista dell’appartenenza: non appartenendo originariamente allo spazio sociale e politico in cui si insedia e vive, “vi immette qualità che non ne derivano e non possono derivarne”. La sua presenza, il suo essere “contemporaneamente vicino e lontano”, induce strategie di “oggettivazione” che ne fanno una sorta di specchio dei codici dominanti all’interno di una società e che lo espongono sempre al rischio di essere trasformato in un “nemico interno”. Ma potenzialmente la presenza e i movimenti dello straniero costituiscono una sfida essenziale a rinnovare, a reinventare l’appartenenza e a riqualificare quell’“eguaglianza generalmente umana” che costituisce la base di una democrazia capace di andare al di là di un popolo definito univocamente dalla sua omogeneità etnica, religiosa o nazionale.
Si vede bene, in questo senso, come lo straniero (il migrante) interroghi la democrazia dal punto di vista della definizione e della composizione del suo soggetto. Come la interroghi dunque in modo radicale. Sono convinto che attorno a questa interrogazione si giochi oggi in buona misura il futuro della democrazia, la sua capacità – che non do per scontata – di reinventarsi e di rinnovarsi di fronte alle sfide che caratterizzano il nostro presente. Una nuova “invenzione democratica”, per riprendere il titolo di un celebre libro di Claude Lefort, non è oggi possibile all’interno dei confini della nazione. È certo un’affermazione controcorrente nell’attuale congiuntura italiana e globale, caratterizzata dall’ascesa di nuovi nazionalismi. È tuttavia necessario ripeterla, svolgerla e qualificarla, se non vogliamo che la nostra opposizione all’interno di questa congiuntura sia meramente difensiva. Non mi sfugge affatto che la ricerca di una democrazia oltre la nazione pone grandi problemi, che sono stati ad esempio affrontati in riferimento alla dimensione europea o più in generale alla “democrazia cosmopolitica”. Non mi diffonderò ora su questi problemi. Vorrei solo ribadire, in riferimento alla figura dello “straniero”, l’importanza di quella sfida a ripensare l’appartenenza (e dunque il soggetto della democrazia) che ho derivato dalla lettura di Simmel. Si tratta di un tema cruciale, che non sono certo il primo a sollevare. In un libro molto bello, Democracy and the Foreigner (2001), Bonnie Honig ci invita ad esempio, attraverso una ricognizione del problema all’interno della tradizione politica occidentale, a vedere nello straniero un soggetto che ha qualcosa da “darci” nella misura in cui ci “prende” qualcosa: ovvero nella misura in cui ci sottrae la falsa sicurezza di una democrazia atrofizzata e ne riattiva il movimento. Lavorando su fonti in parte diverse, Donatella Di Cesare in Stranieri residenti (2017) perviene a conclusioni molto simili, scrivendo che “il migrante smaschera lo Stato”: “dal margine esterno ne interroga il fondamento”. “In tal senso”, conclude Di Cesare, “la migrazione porta con sé una carica sovversiva”.
È possibile pensare come democratica questa “carica sovversiva”? Ancora una volta, vorrei lasciare aperta questa domanda. Quel che è certo è che, come ha spesso affermato – in fondo sulla traccia di Simmel – il grande sociologo algerino Abdelmalek Sayad, “pensare l’immigrazione significa pensare lo Stato ed è lo Stato che pensa se stesso pensando l’immigrazione”. La sfida che emerge qui per la democrazia mi pare evidente: se la democrazia, come ho sostenuto, non è soltanto un sistema istituzionale ma è anche un movimento, il circolo indicato dalle parole di Sayad deve essere spezzato dall’irruzione del movimento democratico, di un movimento che non può prescindere dal protagonismo dello “straniero”, di quei migranti e di quelle migranti che sono oggi sospesi tra l’invisibilità rispetto ai diritti e al “riconoscimento” e un’esasperata visibilità come capri espiatori nel discorso pubblico. È questa irruzione che può qualificare come democratica la “carica sovversiva” che la migrazione porta con sé. Se vi sia spazio oggi per un riconoscimento di tale carica sovversiva da parte della democrazia come sistema istituzionale (se sia dunque possibile una nuova “invenzione democratica” sotto la spinta della sfida che viene dallo “straniero”) è appunto una domanda a cui esito a dare risposta. Si ripresenta qui quello che all’inizio chiamavo il carattere perturbante della parola democrazia oggi. Quel che so è che quotidianamente donne e uomini migranti si battono in mille modi nelle nostre città per conquistare spazi di libertà. Attraverso il riferimento ai Dalit in India e agli afroamericani negli Stati Uniti ho cercato di dare due esempi di lotte e movimenti democratici sviluppati da soggetti per molti versi “invisibili”. In condizioni naturalmente diverse, le lotte dei migranti si ricollegano oggi a quella storia. Nessuna discussione della democrazia può ignorarle.
Vi sono invece oggi molte discussioni delle democrazia che le ignorano, che assumono come un dato di fatto la tendenza alla moltiplicazione dei recinti, degli steccati, dei fili spinati, dei confini. E che pensano magari di ritagliare all’interno di quei recinti lo spazio per un popolo, per una nazione “democratica”. Consentitemi di ribadire che al contrario dobbiamo essere grati allo “straniero”, ai migranti e alle migranti, per il fatto di ricordarci ogni giorno che non vi è futuro per cui valga la pena di battersi all’interno di quei recinti e di quei confini. La politica esige concretezza, esige spazi determinati, ne sono consapevole: ma oggi si tratta di inventare nuovi spazi, di inventare nuovi soggetti di una politica che potrà dirsi democratica soltanto se saprà rinnovare e allargare le basi dell’uguaglianza.
Una postilla, per concludere. Negli ultimi mesi ho contribuito a lanciare e a fare vivere un progetto che si chiama “Mediterranea. Saving Humans”. Abbiamo acquistato una nave e nello scorso mese di ottobre abbiamo cominciato a effettuare missioni di monitoraggio nel Mediterraneo centrale. Come probabilmente sapete, il 18 marzo abbiamo salvato dal naufragio 49 migranti. Liberté, liberté! hanno cantato in coro questi migranti al momento di sbarcare a Lampedusa. Ecco uno spazio – il Mediterraneo – dove quotidianamente è in gioco qualcosa di decisivo per la democrazia. L’invisibilità assume in questo spazio, che si vorrebbe svuotato di ogni presenza capace di recare testimonianza, un significato affatto particolare. Lottare contro quell’invisibilità significa creare le condizioni non solo perché si sappia quanto di osceno avviene ogni giorno (i naufragi, le morti in mare, il respingimento verso l’orrore dei campi di detenzione), ma anche perché si possano udire parole come quelle dei migranti salvati dalla nave di “Mediterranea”, liberté, liberté. Sappiamo riconoscerci in quelle parole, sappiamo ascoltarvi le risonanze di un’“eguaglianza generalmente umana”? Non riesco a immaginare la costituzione di un nuovo soggetto democratico senza questo riconoscimento e senza questa capacità di ascolto, che in fondo ci fanno vedere il nostro stesso profilo stagliarsi nella figura dello straniero.
Vi ringrazio per l’attenzione.
*Testo dell’intervento presentato a:
Torino, Biennale della democrazia 2019
Sabato 30 marzo
DISCORSI DELLA BIENNALE
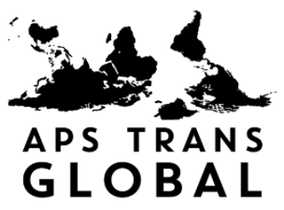
Scrivi commento